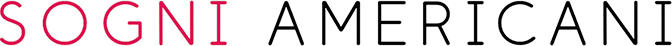Per arrivare al memoriale ci si lascia la scuola alle spalle, si percorre un breve tratto di strada nel traffico, si svolta quasi subito a sinistra e si va fino in fondo, in mezzo ai prati e ai campi sportivi. Baseball, atletica, football, tennis. Il memoriale non si vede, il cartello lo indica al di là di una collina; gli studenti e le studentesse oggi non giocano e i campi sono vuoti. Ci sono anche delle spighe di grano, o qualcosa di simile, su queste colline. Me ne accorgo perché il vento le frusta e il suono che fanno non mi piace.
Questo posto non mi piace.
Saliamo la collina e il memoriale ora compare. È perso nel vento ed è vuoto. Sono vuoti i campi da gioco ed è vuoto quello spazio: un cerchio di mattoni rossi incassato dentro la collina, circondato da mezzo muro di mattoni rossi a sua volta circondato dai fianchi bassi della collina sventrata. Dietro le spighe battute dal vento, sull’orlo di quelle piccole alture da cui si vede un bel pezzo di Colorado, compare allora la scuola, quella che ci eravamo lasciate alle spalle e che ora, in lontananza, ci mostra il suo nome scritto a grandi lettere bianche sul fianco di uno degli edifici: Columbine High School.
La Columbine High School è il liceo che il 20 aprile del 1999 perse 12 dei suoi studenti e un insegnante in quello che diventò lo school shooting per eccellenza, la strage scolastica che segnò l’inizio di un’era, il prototipo di un orrore (quasi) esclusivamente americano che - come abbiamo visto questa settimana - dopo 23 anni miete ancora vittime. Più numerose, anche. Più giovani, persino. Sandy Hook, Parkland, Uvalde. “Perché questo è capitato proprio a noi?” dice una delle frasi incise su quel mezzo muro di mattoni rossi. Forse, penso, il memoriale l’hanno costruito su una collina proprio per questo: per far sì che le domande di chi resta si perdano nel vento.
Entriamo nel cerchio di mattoni, scende continuamente acqua da una fontana a muro producendo un suono che penso dovrei associare alla vita e al ciclo infinito delle cose umane, un’enorme scritta sul selciato dice NEVER FORGOTTEN (mai dimenticatə) e su quello che è stato chiamato il RING OF REMEMBRANCE (l’anello del ricordo) si leggono i ritratti delle 13 giovani persone uccise. Sono parole incise su lastre di pietra scura, sono parole dolci, vere e insopportabili, parole scritte da papà e mamma, da fratelli e sorelle, da amici e amiche, parole che mi rifiuto di leggere. Tutta la varietà di fedi, colori e profili dell’America in un anello di morte. Forse, penso, la fontana l’hanno costruita su un moto d’acqua perpetuo così chi viene qui può confonderci dentro i propri singhiozzi.
Mi allontano dalle vittime e vado verso il muro. L’hanno chiamato WALL OF HEALING che vuol dire muro della guarigione. La prima frase che leggo è quella domanda lì: “Perché questo è capitato proprio a noi?”. Il vento è davvero troppo forte per non pensare che sia lui la risposta. Poi proseguo.
“Non darò mai più nulla per scontato.” (studente)
“Nessuno ci aveva mai preparato a questo; eravamo solo insegnanti che facevano quello che facevano ogni giorno.” (insegnante)
“Un ragazzo della mia età non dovrebbe andare a tutti questi funerali.” (studente)
“La parte più difficile da capire era dei ragazzi che uccidono altri ragazzi." (studente)
“Spero che le persone vengano in questo posto per riflettere su come loro stesse possano essere persone migliori invece che venire qui per riflettere sulla morte.” (genitore)
Ci sono anche le parole dell’allora presidente Bill Clinton, inserite in mezzo a tutte queste, senza differenze. Eppure, quelle che oggi riesco a leggere con più fatica sono quelle che parlano del futuro: “questa tragedia ci ha messo in ginocchio, ma ora che ci siamo rialzati cosa abbiamo imparato?”
Niente. Abbiamo imparato a dimenticare, forse; abbiamo imparato a studiare e spiegare perché una nazione come gli Stati Uniti non può e non vuole rinunciare alle armi; abbiamo imparato i nomi delle vittime di tutti gli school e mass shooting che sono seguiti a Columbine; abbiamo imparato a barricarci nelle aule, a fare le simulazioni, ad accettare che ai nostri figli e alle nostre figlie venisse insegnato a fingersi morti pur di sopravvivere; abbiamo imparato a calmarci dopo lo strazio; abbiamo imparato a indignarci e a smettere di essere indignatə; abbiamo imparato a metterci nei panni dei sopravvissuti o delle madri, abbiamo imparato a soffrire con loro e per loro, e poi abbiamo imparato a smettere di soffrire; abbiamo imparato a mandare preghiere, a vomitare dalla rabbia, a protestare. Abbiamo imparato ad aspettare la prossima volta perché in questa non abbiamo imparato niente.
La sofferenza violenta è estasi, e come l’estasi dura un attimo e crea dipendenza. Shakespeare diceva una cosa del genere nel Macbeth. Lo ha ricordato la poeta Jana Prikryl su Twitter dopo la strage di Uvalde: povera America, non può essere chiamata madre perché è tomba.
Ah, povero paese! Timoroso
quasi di riconoscere sé stesso!
Più non si può chiamarla nostra madre,
ma nostra sépoltura; ove nessuno,
che non sia proprio d'ogni cosa ignaro,
sa più sorridere; dove sospiri
e gemiti e lamenti foran l'aria
inascoltati; dove pene atroci
sembrano ormai un male quotidiano;
dove se la campana suona a morto
nessuno più si domanda per chi;
e la vita delle persone oneste
dura ancor meno di quella dei fiori
ch'esse portano in cima ai lor capelli,
perché muoiono prima d'ammalarsi.
Traduzione di Goffredo RaponiTra le voci che più hanno parlato in questi giorni ci sono quelle dei genitori dei bambini e delle bambine che hanno perso la vita esattamente dieci anni fa, nella strage di massa più sanguinosa se si considerano solo le scuole elementari: Sandy Hook, in Connecticut. A loro è stato chiesto cosa hanno provato rispetto al recente massacro di Uvalde, come hanno imparato a gestire il dolore e il lutto in tutto questo tempo, cosa avrebbe atteso i genitori texani dopo aver seppellito i propri figli e le proprie figlie. Mentre ascoltavo la giornalista Elizabeth Williamson pronunciare questa domanda mi sono risposta, quasi insofferente: “cosa vuoi che li attenda? Disperazione e dolore…”. Ma si può fare di peggio. “Ci sarà qualcuno, in mezzo a quel dolore e quella disperazione,” ha detto la giornalista stessa, autrice di un libro su Sandy Hook che oggi vale la pena leggere (lo trovi qui, è un link affiliato non di Amazon, il libro è in americano), “che cercherà di far credere alla gente che quel massacro è stato una messa in scena, che quei bambini morti sono attori, che quel lutto è una finta, un complotto, una bugia. Queste persone sbucheranno da Facebook, al telefono, qualcuna suonerà anche il campanello di casa. Saranno disposte a fare di tutto per sostituire la realtà con una storia che non le obblighi a fare i conti con ciò che il nostro paese può produrre.”
Di nuovo Shakespeare. Povera America, non è la nostra madre, è la nostra tomba.
Una delle soluzioni su cui oggi i giornali si interrogano maggiormente riguarda proprio il modo in cui raccontano queste storie, ogni volta che si manifestano: forse, iniziano a dire in molti, dovremmo mostrare quei cadaveri, farli vedere anche a chi ha il coraggio di dire che sono finti, dovremmo mostrare la carneficina e il sangue al mondo intero, dovremmo muovere allo sgomento chi ancora sostiene che non sono le armi a uccidere ma le persone. Forse dovremmo ammettere che non abbiamo imparato niente, in tutti questi anni, perché in fondo abbiamo cercato egoisticamente di proteggerci.
Il muro della guarigione del memoriale di Columbine l’ho letto e percorso tutto. Me ne sono allontanata a fatica, come se quella prossimità al dolore degli altri potesse in effetti lenire e consolare il mio. Il vento, l’acqua, il silenzio e i singhiozzi. Né loro né il muro sono bastati però, alla fine, a farmi avvicinare all’anello del ricordo, al ritratto delle 13 vittime, alle parole dei loro cari. Anche io ho scelto di proteggermi quel giorno e, a ripensarci oggi, l’ho fatto perché ne avevo timore: è difficile amare un paese così fosco. Abbiamo imparato ad aspettare la prossima volta perché in questa non abbiamo imparato niente. Eppure sappiamo già che la prossima volta sarà peggiore.
Grazie per avermi seguita fin qui oggi. Non facile. Avrei diverse cose da dire riguardanti i prossimi appuntamenti (festival, tour dei Book Riders, corsi), ma sono certa che troveremo il modo parlarne altrove. Ti dico solo che a partire da giugno questa newsletter raddoppia: uscirà un sabato sì e uno no (quindi non più soltanto l’ultima domenica del mese). Sarà sempre gratuita. Spero che per te sia una buona notizia.
A presto.