Si chiama The Curse ed è, francamente, insopportabile.
Racconta la storia di una coppia - interpretata dai magnifici Nathan Fielder ed Emma Stone - che si trasferisce dalla California a Española, una cittadina autentica (nel senso che non è d’invenzione, ma è reale) del New Mexico, per costruire case ecosostenibili mentre viene ripresa e diventa la protagonista di un tipico reality show che potrebbe andare in onda sulla celebre emittente televisiva americana Home&Garden (HGTV).
Española è un disastro. Uno di quei disastri sociali che in Italia o nelle grandi città americane si fa fatica non tanto a comprendere ma proprio a visualizzare: abitata prevalentemente da persone native e latine, è un microcosmo di disuguaglianza sociale, arretratezza, dipendenze, isolamento, sfruttamento del territorio, lavori umili e mal pagati. Satellite delle più ricche e bianche Taos e Santa Fe, le città d’arte e del turismo del New Mexico che si trovano 50 minuti rispettivamente a nord e a sud, Española sembra raccogliere i loro scarti, pur impegnandosi per quel che può a farne qualcosa, a trarne qualcosa di buono.
Perché una coppia di facoltosi e creativi bianchi californiani sceglie dunque di trasferirsi a Española per avviare la propria attività immobiliar-televisiva? Be’, proprio perché è un disastro. Più disastrosa è la realtà locale da salvare, proteggere e (sulla carta) integrare, migliore sarà la figura che farà la coppia nel realizzare la propria missione.
È questa infatti l’ultima frontiera della gentrification, nonché il nocciolo di quell’ipocrisia che sta al centro della trama di questa serie tv e che la coppia riesce a rendere in maniera talmente cristallina che a volte, mentre la guardi, ti chiedi se non sia surreale, esagerata, troppo americana per essere credibile. Di certo, come dicevo prima e come è giusto che sia, è insopportabile, persino cringe.
Tanto è autentica Española quanto poco lo sono le azioni e le intenzioni dei due: in primo luogo, ogni cosa che li riguarda è mediata da un copione. Non esiste spontaneità, se non repressa o staged, ovvero imbastita per essere ripresa dalle telecamere (incluse quelle del cellulare) e diventare così un messaggio politically correct. Né esiste un qualsivoglia progetto di integrazione ambientale o culturale o economica che non passi attraverso l’uso dei soldi, della carta di credito, di quella moneta che compra tutto, anche e soprattutto le buone intenzioni. Esemplare, in questo senso, è l’episodio dei furti: la coppia, oltre alle proprie case, apre diversi esercizi commerciali, in cui vuole impiegare rigorosamente persone local. In uno di questi, quello che vende abbigliamento, avvengono dei piccoli furti, ad opera di persone povere della comunità, chiaramente non bianche. Così come non bianche sono le commesse. Pur di non “fare scenate” e di non coinvolgere la polizia creando così un danno d’immagine alla stessa comunità che la coppia vorrebbe proteggere, Whitney (Emma Stone) lascia la propria carta di credito alla commessa dicendole di addebitare lì tutti i furti che avvengono in negozio. In altre parole, si compra quella giustizia superficiale che non riuscirebbe mai a garantire nel profondo. Con il risultato che i furti che erano occasionali diventano la norma, sistematici e grotteschi.
Il livello di esasperazione e attrito che suscitano questi episodi è sottile, esattamente come lo è l’atteggiamento di molta cultura cosiddetta woke, che non riesce a mettere all’opera i propri valori senza rinunciare al privilegio sul quale si posano e sono cresciuti. Il modo con cui i due si appropriano dell’arte nativa senza saper rispettare i confini della realtà e quelli della performance, la persuasione con cui aggirano le persone più svantaggiate per farle agire e soprattutto performare a loro favore, il fastidio che provano a compiere un’azione propriamente generosa che non ha un tornaconto, il panico con cui l’uomo della coppia - Asher (Nathan Fielder) - gestisce tanto il proprio organo sessuale quanto la relazione con gli elementi femminili e naturali della storia (la maledizione che dà il titolo alla serie, the curse, arriva da due bambine a cui lui prima dà e poi sottrae dei soldi), tutto questo contribuisce a trasmettere un messaggio che solo nell’ultima puntata esplode in tutta la sua assurda potenza: non c’è nulla di più aleatorio di questi valori, che sono però gli stessi che alla fine ti allontanano dalla realtà nuda e cruda. Senza possibilità di ritorno.
Il finale vale l’intera serie, non lo svelo qui, ma ti invito ad arrivare a vederlo.
Ci saranno sempre delle cose che noi faremo fatica a capire della società attuale degli Stati Uniti, anche se molti dei suoi riverberi arrivano fino a noi e in qualche modo caratterizzano anche la nostra di società. Sono certa che l’ipocrisia e l’allontanamento dai reali bisogni della gente tipici di una certa cultura liberal, soprattutto quando diventa estrema e sorda, sia una di queste. Non basta a spiegare lo straordinario e scellerato accanimento dell’amministrazione Trump contro principi e ideali che rimangono fondanti di una democrazia sana, tuttavia può dare l’idea del sentimento di alcuni elettori che da quella estremizzazione (se non proprio alienazione) si sono voluti allontanare. O anche proprio liberare.
Il punto della situazione
Marzo è stato un mese di giro: è cambiata la mia immagine pubblica, Sogni Americani ha inaugurato la sua nuova veste grafica e anche una nuova rubrica (The Monthly), ho fatto ordine nel piano editoriale (le sezioni Libri e Interviste sono nate apposta), nel sito e nei piani di abbonamento. Volevo pulizia di intenti e una direzione rinnovata, condizioni essenziali per me per continuare a fare questo lavoro al meglio delle mie possibilità, usando e offrendo strumenti affilati in un tempo così confuso, estenuante, fosco come quello che stiamo vivendo.
Non posso nasconderti, tuttavia, che le mie possibilità sono limitate e che questo tempo sta cambiando diverse cose: dalla voglia delle persone a viaggiare negli Stati Uniti alle fondamenta più profonde che sostengono la mia attività di ricerca e divulgazione. Si possono fare oggi le stesse cose che si facevano prima, magari anche nello stesso modo, raggiungendo gli stessi risultati?
Non penso. Non per me almeno, che ho come obiettivo non solo il sacrosanto campare, ma anche creare cambiamento, conoscere il mondo per migliorarlo, fare contronarrazione.
Non voglio abbandonare la nave, sia chiaro, ma credo sia tempo di considerare di cambiare la rotta. In un momento in cui gli Stati Uniti si isolano e si rendono respingenti, io vorrei andare più a largo, osservare la loro azione in altre parti del mondo, trovare storie che colmino la distanza di quell’isolamento premiando però - in termini di considerazione - non la forza ma la resistenza, non chi sta dentro i confini ma chi li subisce o ne resta fuori.
In sostanza, non l’America ma gli altri. Il Canada, Puerto Rico, i Caraibi, il Messico. Ma anche la Groenlandia, Panama, il Venezuela, la Francia. I Navajo, gli Inuit, i rifugiati.
Il corso sul New Mexico ha già inaugurato questa linea, così come la puntata di Miglia su Nairobi e New York e diverse delle notizie che hai trovato nel Monthly di marzo. Andremo avanti così. Il centro rimarrà stabile ma lo sconfinamento sarà sempre più frequente, le aste del compasso - dunque - sempre più larghe.
Che ne dici?
Sogni Americani è e rimarrà gratis. Ma, a partire da maggio, il suo archivio diventerà a pagamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che continuerai a ricevere la newsletter alle stesse condizioni di prima, ma potrai leggerle gratuitamente solo in un lasso limitato di tempo di due settimane. Per continuare a consultarle dalla homepage (una condizione più simbolica che altro, nella tua casella di posta la newsletter rimarrà infatti leggibile) e, più in generale, per supportare il mio lavoro potrai sottoscrivere un abbonamento mensile di 5 euro o annuale di 50.
Ne riparliamo nel dettaglio più avanti, intanto - se vuoi - l’opzione per l’upgrade è già attiva (guarda sotto).
Grazie. Ci risentiamo tra due settimane, se tutto va bene dal Texas. Ciao!

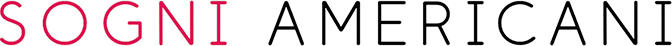







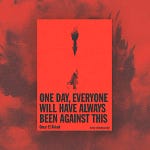





Share this post