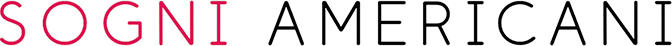Sono trascorse appena due settimane dall’ultima newsletter (quella in cui raccontavo il caso della candidata Jill Stein) eppure sembra trascorso un intero anno. Le elezioni americane ci hanno gettato in un mondo in cui Trump - che in campagna elettorale aveva promesso un governo totalizzante - di fatto sta già occupando la totalità della scena. Causando quella che l’altra sera a cena la mia amica e collega Luciana Grosso ha chiamato la Trump fatigue, ovvero la stanchezza psicologica, la pesantezza che la sua figura causa in tutti e tutte noi, già adesso.
Non parlerò quindi di lui oggi, qui. Ho trascorso la mattina a recuperare articoli, analisi e dati sul suo prossimo governo e quella fatigue la sento proprio tutta. Inoltre, non ho più molto da dire: ho commentato l’esito delle elezioni insieme a Giammarco Sicuro e Veronica Fernandes in una puntata di Mappamondi (la puoi vedere nel video lì sotto o ascoltare qui) e nell’ultima tappa della newsletter States, proprio insieme a Luciana Grosso (la puoi leggere qui, è open). Ti rimando a questi contenuti per conoscere le mie riflessioni, se sono di tuo interesse.
Questa newsletter, inoltre, cerca di fornire ai propri lettori e alle proprie lettrici degli strumenti utili per comprendere la cultura e la società degli Stati Uniti in modo costante, di mese in mese: l’elezione di Donald Trump non dovrebbe averti colto del tutto di sorpresa, dunque, ma se sei tra le persone che ancora stanno cercando dei segnali o delle storie per “spiegarsi” questo risultato, prova a leggere o rileggere la puntata sul muro come soluzione migliore, quella sulla solitudine della società statunitense, quella sull’impossibilità di definire i Latinos come una categoria omogenea, quella sull’impatto delle politiche di Washington sulla vita comune delle famiglie e quella - infine - sul momento di profonda crisi che sta attraversando il Paese non certo dal 5 novembre (forse soprattutto questa).
Fallo, perché qui, oggi, racconterò un’altra storia. Una storia bella. O per lo meno incoraggiante. Una storia che ha a che fare con le case e con le storie nascoste che vengono scritte al loro interno.
L’uomo che vedi in questa fotografia si chiama Henry Robinson, fu uno schiavo. Fu intervistato tra il 1936 e il 1938 dal programma governativo Federal Writers Project voluto dal presidente Roosevelt per raccontare lo spirito della nazione negli anni della Grande Depressione e, in particolare, fu uno dei protagonisti del programma battezzato Slave Narrative Collection: una raccolta di testimonianze che coinvolse circa 3.500 persone afroamericane che vissero in schiavitù e furono dunque invitate a raccontare di sé. Offrendo, come nel caso di circa 1.010 di loro, anche dei dettagli sulle case in cui avevano vissuto. Case che in buona misura oggi non esistono più o sono state abbandonate, ma che in qualche occasione sono state conservate, convertite in abitazioni di uso corrente o in garage, trasformate addirittura in bed&breakfast. E diventate protagoniste di una ricerca virtuosa, quella che è arrivata in forze fino ai nostri giorni e oggi ti racconto.
Il progetto si chiama Saving Slave Houses, ad avviarlo nel 2011 è stata l’architetta dell’Iowa Jobie Hill con il proposito di preservare, censendole anche, il maggior numero di case appartenute agli schiavi e alle schiave nere presenti sul territorio degli Stati Uniti (del Sud, soprattutto), sia per educare chi le visita o le incontra in giro sia per salvare le storie che hanno preso vita al loro interno. Storie che, la maggior parte delle volte, sono state forme di resistenza alla schiavitù, momenti di ritualità privata, spiragli di quel poco di libertà che veniva concessa a queste persone giorno dopo giorno. Una forma di intimità e sicurezza tanto preziosa per gli schiavi e le schiave quanto immediatamente riconoscibile nella sua universalità da chiunque scelga di mettersi in ascolto: Jobie Hill è sicura di questo ed è per questo motivo che parte della sua ricerca si impegna ad analizzare il modo in cui queste case venivano non tanto arredate (i padroni permettevano agli schiavi davvero pochissimo in termini di arredamento o men che meno comfort) quanto arrangiate e caratterizzate dall’uso di diversi materiali, oggetti, strumenti, ricordi. Fango, reti dei letti, finestre, rastrelli, corde, ad esempio.
E poi, ancora più importanti degli elementi riconoscibili, lo diventano quelli unici e caratteristici, quelli che non possono essere persi o andare dimenticati: come vivevano gli schiavi? Quali erano i loro spazi e in che modo li abitavano? Cosa ci raccontano le pareti ancora in piedi delle parole e dei silenzi che venivano scambiati al loro interno?
L’architetta ha visitato più di 700 di queste case, molte in stato di abbandono o quasi del tutto distrutte, e il suo è l’unico censimento di questo tipo esistente negli Stati Uniti. Questo lo rende piuttosto significativo, ma a renderlo tale ancora di più sono la precarietà del metodo (spesso lei e i suoi collaboratori o allievi trovano tracce di una casa di schiavi da fotografie delle vecchie piantagioni in cui a essere inquadrata volontariamente è sempre e solo la casa padronale), lo scarso numero di eredi o di testimoni, la difficoltà con cui da una casa individuata oggi si riesce a risalire alla storia delle persone che l’hanno abitata. Il suo fine ultimo, infatti, è quello di connettere le abitazioni rilevate e censite grazie al suo progetto alle storie di quei 1.010 individui che parlarono delle proprie case negli anni Trenta, uomini e donne come Henry Robinson.
These are buildings history has long overlooked, because they do not make the white male a hero.
Nel paesaggio naturale e umano degli Stati Uniti di oggi la schiavitù è invisibile: non c’è alcun segno visibile che la racconti o la testimoni, prima che lo faccia il discorso storico o quello sui diritti civili. L’azione di un lavoro come quello di Jobie Hill è rilevante, quindi, proprio perché impedisce ai segni del tempo e a quelli del razzismo di cancellare anche i segni della storia. E della colpa: spesso queste storie non vengono conservate perché rendono l’uomo bianco tutto tranne che un eroe. A dirlo è Joe McGill, il fondatore di un altro progetto simile, chiamato The Slave Dwelling Project, dove al processo di conoscenza delle case degli schiavi si unisce anche l’idea di farci dormire dentro le persone. Per una notte, in modo consapevole e “assistito”, per capire qualcosa in più a partire da ciò che l’esperienza lascia sulla propria pelle. Appunto.
Tu lo faresti?
Avvicinarci a queste storie ed educarci a un racconto più veritiero dell’esperienza della schiavitù è un processo che può passare attraverso tante strade diverse. Io e alcuni Book Riders abbiamo avuto la fortuna di percorrere quella della Whitney Plantation, tempo fa. La consiglio anche a te, se mai andrai in Louisiana: è interamente raccontata dal punto di vista delle persone schiave.
Come dice Jobie Hill, la casa è un luogo sacro per tutti, ma non per tutti è un luogo altrettanto protetto.
Grazie
L’ultima sezione di Sogni Americani è sempre dedicata alla prosecuzione del viaggio: appuntamenti dal vivo, contenuti della membership, altri posti dove trovarci. Lo sarà anche oggi, ma prima ci tengo a ringraziare davvero di cuore le persone che hanno seguito States nell’ultimo anno supportando il progetto con i propri soldi e chi fa o ha fatto lo stesso con i programmi della membership della McMusa (Miglia, Mac&Cheese e LIT).
So quanto un abbonamento possa pesare sulla gestione delle risorse di una persona sola, di una coppia e di una famiglia e so anche quanto sostenere una piccola realtà di giornalismo e divulgazione indipendente come la mia sia una scommessa nel già affollato mondo dell’informazione a pagamento in Italia e negli Stati Uniti. Bisogna fare delle scelte, le faccio io per prima, e, quando sono proprio io a venire scelta, il significato di questo processo non lo dimentico di certo.
Grazie, quindi. Ci sto mettendo davvero tutta la passione, la professionalità, l’attenzione e l’empatia possibili per offrirti il meglio. E così fanno anche le persone che lavorano e collaborano con me.
Sono dunque molto contenta che il periodo di prova della membership abbia attirato così tante persone (siamo a +20.5%!). La promozione rimane attiva fino al 26 novembre. Ti invito ad approfittarne per goderti le storie nuove: la puntata di Miglia su Detroit (quanto ho adorato farla, sono certa che si sente!), la newsletter Mac&Cheese in arrivo domenica 17 novembre dalla penna di un’ospite molto esperta di contaminazioni, il bookclub LIT su quel balsamo che è il reportage Viaggi con Charley di John Steinbeck. Anche tutti i contenuti passati sono a disposizione, dai un’occhiata.
Noi ci risentiamo tra due settimane, grazie per avermi seguita fin qui. Guardiamo avanti. Guardiamo con attenzione, ma avanti. Ciao!